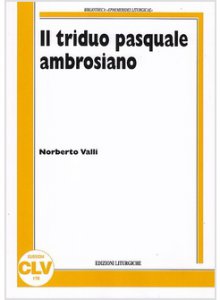In questi giorni della Settimana Autentica riteniamo utile offrire una presentazione della liturgia delle principali celebrazioni grazie ad una sintesi de "Il triduo pasquale ambrosiano", testo di don Norberto Valli, docente di Liturgia del Seminario e noto esperto nel campo. Buona lettura e preghiera a ciascuno!
Un punto di partenza
Nella celebrazione del Triduo Pasquale la Chiesa fa memoria della passione – morte – sepoltura – risurrezione di Gesù Cristo. E’ questo il momento vertice dell’intero anno liturgico, momento cioè della ricapitolazione di tutto l’agire salvifico del Padre nei confronti del mondo. È questo il momento fonte della fede-speranza-carità della Chiesa, la festa, che dà origine a tutte le feste e autorizza la loro celebrazione.
Scriveva J. Ratzinger, prima che diventasse papa:
E’ valso in tutte le culture il principio che la festa presuppone un’autorizzazione che i partecipanti alla festa non possono darsi da se stessi. Non si può decidere di celebrare una festa, essa ha invece bisogno di un fondamento e per di più oggettivo, che è anteriore ai propri desideri. …dove la festa viene fatta coincidere con interazioni comunitarie e la libertà viene scambiata con la «creatività» di trovate artefatte, l’umanità è ridotta ad una fiammata e, per quanto belle possano sembrare le parole, la vera domanda è evitata… La festa presuppone l’autorizzazione alla gioia; quest’autorizzazione è valida solo se è in grado di far fronte alla domanda sulla morte… la risurrezione di Cristo dà l’autorizzazione alla gioia ricercata da tutta la storia e che nessuno era in grado di fornire
(J. Ratzinger, La struttura della celebrazione liturgica, «Communio» 41 (1978) 24-34. Ripreso in Idem, La festa della fede. Saggi di teologia liturgica, Jaka Book, Milano 1984, 67-81).
Splendida intuizione che possiamo applicare al nostro discorso: nel mistero pasquale è insita l’autorizzazione alla festa vera, reale, perché finalmente possiamo essere certi che la nostra vita non è destinata a finire nel nulla. Cristo muore e con la sua vittoria sulla morte ci rivela la meta verso la quale siamo incamminati, ossia la vita eterna.
Ecco il mistero pasquale che, in fondo, è al principio di ogni nostra Eucaristia, festa della risurrezione in quanto porta in sé il mistero della croce che è poi l’intima premessa della risurrezione.
Nella storia della Pasqua l’unico mistero pasquale celebrato dalla Chiesa e dalle Chiese, ha avuto una pluralità di letture teologiche, che accentuavano di volta in volta un elemento di verità di questo mistero. Di tale ricchezza di prospettive è ancora oggi debitrice la celebrazione liturgica ambrosiana del Triduo santo, che possiamo dire, le raccoglie mirabilmente in unità, mentre percorre quasi in ordine cronologico i momenti della cena, del tradimento, dell’agonia, della passione, morte, sepoltura e risurrezione del Signore.
Un detto giudaico dice che per strappare un uomo da un pozzo profondo in cui è caduto non basta tendergli la mano, bisogna scendere là dov’è e tirarlo fuori. Ecco il mistero della Pasqua: il Figlio di Dio scende fino al punto estremo in cui l’umanità può precipitare, ossia la morte. La vive nella sua drammaticità e ci strappa da questa prigionia per restituirci la vita.
- Pasqua: vittoria della luce sulle tenebre
Si comprende così il simbolismo luce-tenebre che sempre contraddistingue le grandi celebrazioni del Triduo.
“Dio mio rischiara le mie tenebre” si canta durante il lucernario della messa vespertina in cena Domini che dà inizio al giorno della passione. Le tenebre del male e della morte rimangono però sempre in agguato; noi chiediamo dunque al Signore di illuminarle con la sua grazia quando si apre il giorno di passione, la sera del giovedì, e quando la liturgia ci conduce presso la croce a contemplare la morte di Gesù. Quasi come monito l’inno vespertino del giovedì santo ci richiama che mercator ille pessimus solem tenebris vendidit (Giuda, quel mercante pessimo, vendette il sole alle tenebre). Significativamente allora nell’orazione che conclude l’Eucaristia, imploriamo “di non essere coinvolti nelle tenebre del discepolo infedele, ma di riconoscere in Cristo il nostro Salvatore”.
Il simbolismo liturgico ci permette di entrare nel dramma, racchiuso nelle parole con le quali l’evangelista Matteo descrive il comportamento dei discepoli nell’ora decisiva per Gesù: “tutti, abbandonatolo, fuggirono”. La nostra fedeltà è continuamente minacciata dalle debolezze e dalle miserie che ci contraddistinguono. “Non siete stati capaci di vegliare un’ora sola con me? – dice Gesù ai suoi – Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole”: parole del vangelo della messa vespertina in cena Domini che echeggiano nei canti.
A ben vedere, già nella vicenda di Giona, narrata nella lettura veterotestamentaria, si coglie molto nitidamente il contrasto tra l’agire di Dio e quello dell’uomo. Davanti alla disponibilità senza limiti del Signore nei riguardi delle sue creature, il profeta si ribella. Cerca prima di sottrarsi all’opera di salvezza a cui Dio lo chiama e, nonostante il bene sperimentato nelle sue vicissitudini, arriva a indispettirsi per la pietà provata da Dio per i Niniviti che si convertono. Il cuore dell’uomo diviene, talvolta, inspiegabilmente duro, incapace di stupore, chiuso nel proprio egoismo. Eppure Dio non smette di attirarlo a sé. Persino quando l’uomo non è disponibile alla comunione con lui, la forza dell’amore di Dio non si arrende.
Emblematica appare, ai nostri occhi, in questa dinamica di tenebra e luce la figura dell’apostolo Pietro, che segue Gesù, ma mantiene le distanze: “se ne stava seduto fuori” – annota l’evangelista; non era pronto ad affrontare le conseguenze di una presa di posizione dichiaratamente a favore del Maestro. Di fronte a chi lo smaschera, Pietro non può fare altro che ribadire la sua estraneità a Gesù. Non ha la forza di affermare che è uno dei suoi discepoli.
Al canto del gallo, c’è però il pianto amaro di Pietro. È in questa consapevolezza della propria povertà che lui può riconoscere la fedeltà di Gesù. Il suo pianto amaro è come un lavacro rigenerante. Non avrà comunque il coraggio di stare con Gesù, di accompagnarlo alla morte; in quelle lacrime, tuttavia, c’è la sconfitta dell’amor proprio e il riconoscimento della fedeltà di cui il Signore è capace. In quelle lacrime è racchiusa tutta la nostra debolezza, la nostra difficoltà ad essere coerenti nella testimonianza, la nostra fatica a vivere la fede nel Signore Gesù. Ma insieme c’è la dichiarazione che, lontani da lui, siamo perduti, non sappiamo più chi siamo realmente, qual è la nostra meta, quali sono i passi da compiere.
Il vertice del simbolismo luce e tenebra si raggiunge nel venerdì santo. Dopo aver implorato il Signore di rischiare le nostre tenebre, all’inizio dell’azione liturgica, che pure non dovrebbe essere di per sé vespertina, avvertiamo che quel lucernario se non è propriamente rispettoso della cronologia degli eventi rimane fortemente teologico: il buio sceso su tutta la terra è rischiarato dalla croce di Cristo. E allora, quando nel corso della narrazione evangelica, anamnesi quasi sacramentale della morte, tutte le luci si spengono, comprendiamo che quella sarebbe la costante condizione dell’umanità, un buio privo di speranza, se non avessimo la certezza che, attraverso la morte, Cristo ci ha aperto il passaggio alla vita. Ma ecco la forza simbolica della liturgia ambrosiana: anche in quell’ora tremenda, mentre tutto tace e ogni luce è spenta, presso il tabernacolo, dove è stata riposta l’Eucarestia la sera precedente, una lampada continua ad ardere e conserva questa luce, a differenza della liturgia romana, persino nel secondo giorno, quello del grande silenzio. Noi celebriamo la morte di colui che è per sempre vivo in mezzo a noi nel sacramento del suo corpo e del suo sangue.
Il tema della luce che squarcia le tenebre è evidente anche nella grande veglia. La nostra tradizione privilegia la benedizione della lampada, da cui si attinge nel buio della notte, la fiamma per accendere il cero pasquale, segno della luce spirituale che sorregge l’attesa e guida il cammino della Chiesa verso l’incontro con il suo Signore. Il cero non è dunque nella Veglia ambrosiana diretto simbolo del Cristo risorto come nel rito romano, ma è come «la colonna di fuoco che precede il popolo del Signore nella notte» e come la stella che ha guidato i Magi all’incontro con il Signore, per usare le espressioni del preconio. L’illuminazione del Battesimo o la memoria battesimale attraverso l’aspersione è il naturale sviluppo di questa concezione; dopo essere stata illuminata e purificata dal lavacro di rigenerazione, la Chiesa Sposa può muovere splendente verso il suo Signore che incontra nell’Eucarestia. Non possiamo dimenticare che prima della riforma i riti battesimali precedevano lo stesso annuncio della risurrezione, in accordo con quanto annunciato alla fine del preconio, e l’alleluia si sprigionava proprio a partire dal Fonte, mentre i fedeli venivano aspersi con l’acqua benedetta.
- Pasqua/passione
Dopo aver messo in risalto la simbologia della luce, cerchiamo di cogliere l’interpretazione della Pasqua che viene proposta, sotto varie angolature, nei diversi momenti celebrativi del Triduo. A essere sottolineata è anzitutto la Pasqua come mistero della passione del Signore. Immediatamente ci viene da pensare al venerdì santo. In realtà questo tema del patire di Cristo percorre l’intero triduo. La nostra tradizione ambrosiana già la sera del giovedì santo rivive gli eventi che introducono alla passione del Signore. Mentre contempla Gesù che consegna se stesso, considera pure il dramma dell’umanità che lo tradisce. In latino l’unico verbo tradere esprime questa opposizione, in quanto significa sia “consegnare” che “tradire”. Nella sua misericordia infinita il Figlio di Dio si consegna senza riserve e la meschinità del discepolo, che non comprende l’amore infinito e incondizionato, risponde con il tradimento, la consegna a “sacrilego prezzo”.
“Nella notte in cui fu tradito” – sottolinea Paolo scrivendo ai Corinzi – Gesù spezza il pane e condivide con i suoi il calice della nuova alleanza nel suo sangue. Non attende che il loro spirito sia pronto. Al contrario dà tutto se stesso, proprio quando uno di loro lo vende al Sinedrio e gli altri sono ormai prossimi ad abbandonarlo. In questo contesto di contrarietà, di rifiuto, di negazione dell’amore viene pronunciato il sì definitivo di Dio per la salvezza dell’umanità. Gesù, nonostante tutto, desidera mangiare la Pasqua con i suoi, vuole che i discepoli preparino la cena pasquale, nella quale le promesse antiche si compiranno. La storia inizia così un nuovo cammino, perché “il Figlio dell’uomo se ne va, come è scritto di lui”, eppure continua ad accompagnare i suoi verso la patria definitiva, in una forma non più fisica, ma sacramentale. La sua presenza non finisce; permane, indelebile, nel pane spezzato e nel calice benedetto, memoria viva del gesto compiuto nella cena e affidato alla Chiesa, perché fosse tramandato nei secoli, fino alla sua venuta nella gloria. Nella forma sensibile del pane e del vino consacrati, saranno sempre visibili i segni posti da Gesù stesso per renderci partecipi della sua offerta al Padre.
Nel venerdì santo, notiamo come il momento culminante della rivelazione di Dio all’umanità sia proprio il corpo sfigurato del crocifisso: “Davvero costui era Figlio di Dio”: sono le parole pronunciate dal centurione che risuonano al termine della solenne proclamazione della Passione del Signore. Le profezie di Isaia riguardanti il servo sofferente si realizzano. Le parole del salmo 21 trovano compimento in Gesù. È Lui l’orante che può pronunciarle in assoluta verità: Hanno forato le mie mani e i miei piedi… Essi mi guardano, mi osservano si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. Il Figlio eterno assume il volto sfigurato di tutti i senza volto, di tutti i disprezzati. Dio si manifesta nella debolezza estrema. Accetta di essere bestemmiato, deriso, colpito, senza reagire. Colui che è della stessa sostanza del Padre, Dio da Dio, Luce da Luce, accoglie in sé il buio della nostra morte, sperimentandola in uno dei modi più atroci. L’antica alleanza è stata spezzata dall’infedeltà dell’uomo, ma la maledizione che si sarebbe dovuta abbattere su di noi Gesù la presa su si sé, Lui, l’innocente, il santo, il benedetto. I carmi del Servo sofferente ci aiutano ad entrare nel mistero di questo dolore salvifico. La voce di Isaia risuona nelle nostre chiese, annunciando che “per le sue piaghe siamo stati guariti”. Le piaghe sono la manifestazione per antonomasia della malattia e della sofferenza di un corpo. Nel caso di Gesù, invece, le piaghe sono origine e causa di salvezza. La sofferenza della croce infatti non è un castigo voluto da Dio, ma un’ingiustizia inflitta dagli uomini. Abituati a ritenere che è prima di tutto il peccato la causa dei patimenti umani, intuiamo che nel dolore di Gesù avviene qualcosa di totalmente nuovo: il peccato è solo nostro, ma la sofferenza è diventata sua. La relazione peccato-castigo è infranta. La croce di Gesù ci dona la guarigione dai nostri mali, genera in noi il pentimento che conduce a una vita rinnovata. Dalle piaghe sanguinanti del suo corpo veramente scaturisce la fonte della salvezza. Il dolore assume una forza insospettata, una fecondità straordinaria. Per vie misteriose, chi partecipa alla sofferenza di Gesù si unisce intimamente a lui e diviene solidale con i fratelli che sono nella prova. Ciò che sembra una maledizione, si tramuta in principio di vita, come accade per i dolori del parto, necessari per generare una nuova creatura.
E così ancora, nella Veglia pasquale, la chiesa ambrosiana torna a contemplare il sacrificio di Cristo. Nel Preconio all’inizio della grande vigilia, canta che è veramente giusto rendere grazie al Padre, perché Egli ha donato agli uomini la vera e definitiva Pasqua, quella del Figlio suo Unigenito. Tale mistero d’amore (il mistero pasquale) è presentato mediante la categoria dell’immolazione sacrificale: Tu hai consacrato la Pasqua per tutte le genti senza immolazione di pingui animali (non pecudum cruore nec adipe), ma con il corpo e il sangue di Cristo, tuo Figlio Unigenito…Una vittima sola ha offerto se stessa alla tua grandezza, espiando una volta per sempre il peccato di tutto il genere umano (mundi totius expiaret offensam)… Questa vittima è l’Agnello, prefigurato dalla legge antica; non è scelto dal gregge, ma inviato dal cielo.
È ancora in forte evidenza la lettura della Pasqua come passione secondo la primitiva predicazione pasquale; tra i «simboli» pasquali, risulta centrale quello dell’agnello immolato. Come nell’antica Pasqua veniva immolato l’agnello, che poi era mangiato nella cena pasquale, così nella nuova Pasqua Cristo è il vero Agnello immolato per noi. Non a caso, tra le letture dell’antico testamento, la veglia ambrosiana conserva proprio il brano di Es 12, in cui nel sangue dell’agnello è assicurata la salvezza agli Israeliti.
Persino nella domenica di Pasqua è custodita in modo del tutto singolare, la memoria della Pasqua di crocifissione, riletta attraverso le prefigurazioni veterotestamentarie:
Cristo Gesù, che possiede con te la natura divina, per liberare l’uomo si è offerto volontariamente alla morte di croce. Egli è stato prefigurato nel sacrificio dell’unico figlio di Abramo; il popolo di Mosè uccidendo l’agnello senza macchia, ne preannunciava l’immolazione pasquale; i profeti lo hanno previsto già nei secoli antichi come il servo che avrebbe portato i peccati di tutti e di tutti cancellata la colpa. Questa è la vera Pasqua, esaltata dal sangue di Cristo nella quale, o Padre, la tua Chiesa celebra la festa che dà origine a tutte le feste.
- Pasqua/passaggio
Accanto a questa forte accentuazione, tipica delle celebrazioni pasquali ambrosiane, si può cogliere una seconda prospettiva: quella della Pasqua come passaggio, passaggio liberatore di Dio e conseguente passaggio dell’uomo, dal peccato alla virtù, dalla schiavitù alla libertà e alla novità dell’esistenza redenta. In questa rilettura teologica della Pasqua l’accento è posto sulla pasqua della Chiesa, sulla nostra Pasqua. Il baricentro risulta spostato da Cristo all’uomo, perché è l’uomo che deve ormai passare dal peccato alla virtù, dal mondo a Dio. Così si esprime sant’Ambrogio:
Fu di primavera che i figli di Israele lasciarono l’Egitto e passarono attraverso il mare, battezzati nella nube e nel mare, come disse l’Apostolo, e in quel tempo ogni anno si celebra la Pasqua del Signore Gesù Cristo, cioè il passaggio delle anime dai vizi alle virtù, dalle passioni della carne alla grazia e alla sobrietà dello Spirito, dal lievito della materia e della malvagità alla verità e alla sincerità”.
Si comprendono bene in questa prospettiva sia la IV lettura che la VI lettura della Veglia, invito per i catecumeni ad accedere al battesimo, ma anche ai battezzati a rinnovarsi interiormente. L’oracolo di Isaia proclama: Così dice il Signore Dio: / «Lavatevi, purificatevi, / allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. / Cessate di fare il male, / imparate a fare il bene, / cercate la giustizia, / soccorrete l’oppresso, / rendete giustizia all’orfano, / difendete la causa della vedova. Questo passaggio esistenziale può avvenire solo grazie alla passione di Cristo. Tramite la passione sofferta per la nostra salvezza il Signore è passato dalla morte alla vita, aprendo anche a noi, che crediamo nella sua risurrezione, il passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia: “Passione e Risurrezione del Signore, ecco la vera Pasqua” – scriverà Agostino.
- La tensione verso il compimento definitivo
Una terza prospettiva, tipicamente ambrosiana, è da sottolineare: quella nuziale e dunque escatologica. Nei tre giorni del Triduo la Chiesa, Sposa di Cristo, rivive con intensa partecipazione e interiore commozione gli eventi ultimi della vita terrena del suo Sposo. Arriva a spogliarsi di ogni ornamento nel momento della sua morte. Nella rinnovata impostazione delle celebrazioni, la memoria della sepoltura e poi della custodia del sepolcro è come se indicassero la sosta silenziosa della Chiesa, attonita di fronte al dramma consumatosi. La lettura delle pagine dell’antico Testamento sostiene l’attesa della Risurrezione. Come i tre fanciulli nella fornace sono liberati dalla morte, così Cristo sarà strappato dalla corruzione del sepolcro, la morte non potrà prevalere: è la teologia della rinnovata celebrazione della Deposizione, elemento prezioso che ci riporta ai riti dell’antica Gerusalemme.
L’attesa trepida nella notte della Pasqua è sottolineata dal preconio: “teniamo dunque le fiaccole accese come fecero le vergini prudenti; l’indugio potrebbe attardare l’incontro con il Signore che viene”. Come nella parabola evangelica, nel cuore della notte si ode un grido: Ecco lo Sposo, così nel cuore della Veglia risuona la voce apostolica del sacerdote che annuncia: Cristo è risorto. Fin dall’inizio della Settimana autentica, del resto, risuona il monito: “Vegliate in ogni momento, pregando…”. Ma perché “tutto il mistero si compia” il popolo dei redenti deve celebrare il banchetto nuziale: si deve nutrire del corpo e del sangue di Cristo, vero Agnello pasquale. L’Eucarestia culmine della Veglia inaugura il tempo lietissimo, come dicevano i Padri, di cinquanta giorni, nei quali la Chiesa esulta per la presenza del suo Sposo che, tornando al Padre, le fa dono dello Spirito santo. L’Eucarestia, culmine della Veglia, è pegno, è anticipazione delle nozze eterne dell’umanità con il suo Signore. Per questo, spezzando il Pane consacrato, nella notte e nel giorno di Pasqua, sono proposte le parole ispirate di san Giovanni Damasceno: Morivo con te sulla croce, oggi con te rivivo. Con te dividevo la tomba, oggi con te risorgo. Donami la gioia del regno, Cristo mio salvatore. Alleluia.
La preghiera liturgica sembra insistere nel rinviarci all’atteggiamento del ladro sulla croce: “Donami la gioia del regno”, in perfetta inclusione con quel “Memento mei, Domine, in regno tuo” (“Ricordati di me, Signore, nel tuo regno”) che sigilla il canto dopo il Vangelo (Caenae tuae mirabili) della santa messa nella Cena del Signore, da noi condiviso con i fratelli dell’Oriente bizantino.